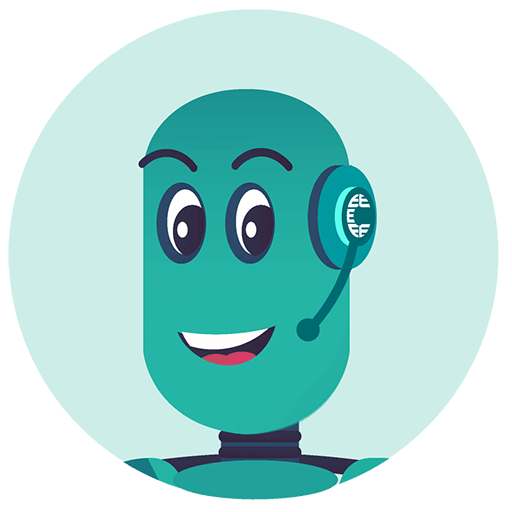La Corte di Cassazione, VI Sez. penale, ha depositato la sentenza n. 4920, del 31 gennaio 2019, che appare di fondamentale importanza per gli sviluppi che concernono la delicata vicenda relativa alla liceità della vendita della cannabis prodotta nell’ambito descritto dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
Tale sentenza afferma, in sostanza, che né il dPR n. 309/90, in materia di stupefacenti, né norme successive all’entrata in vigore della legge n. 242 fanno sì che ai prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa rientrante nei limiti di THC previsti dalla stessa legge possano essere attribuite caratteristiche di illiceità, sì che la commercializzazione di detti prodotti, comprese le infiorescenze, deve ritenersi consentita.
Va subito detto che l’emissione della sentenza non risolve il problema, poiché sposta la soluzione al livello giudiziario, ma essa costituisce comunque un momento importante nell’evolversi della vicenda, di cui deve prendersi atto.
La sentenza, va subito evidenziato, appare in contrasto con l’impostazione data al problema dal Ministero dell’Interno, che solo pochi mesi fa aveva emesso una nota, commentata dallo scrivente Ufficio con la circolare n. 4645, del 29 gennaio scorso, in cui affermava che le norme di cui alla legge n. 242/2016 non avrebbero un effetto generalizzato, ma riserverebbero solo alla figura del coltivatore un’area di irresponsabilità entro il limite dello 0,6% di THC, senza per questo derogare alla disciplina di cui al T.U. sugli stupefacenti, e di fatto metteva in guardia i commercianti della cosiddetta “cannabis light”, sostenendo che le iscrizioni poste sulle confezioni, sui siti e nei negozi non escluderebbero la responsabilità del venditore e dell’acquirente, poiché consentire che la soglia dello 0,6% agisca non solo quale limite massimo per l’applicazione della causa di esclusione della responsabilità del coltivatore, ma anche come parametro per la legittimazione della vendita delle infiorescenze separate dalla pianta di canapa, rappresenterebbe un’applicazione strumentale, oltre l’intenzione del legislatore.
Di segno contrario la sentenza che qui si commenta, con la quale, fra l’altro, la Cassazione ha mutato orientamento rispetto a precedenti proprie interpretazioni della norma.
Sempre la VI Sez. penale, infatti, con sentenza del 17 dicembre 2018, n. 56737, aveva affermato che “l’introduzione della L. 2 dicembre 2016, n. 242, che, stabilendo la liceità della coltivazione della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish), non si estende alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati, che continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal dPR n. 309 del 1990, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile”.
La Suprema Corte, con la sentenza del 31 gennaio, parte invece dall’assunto che “lo 0,6% è la percentuale di THC al di sotto del quale la sostanza non è considerata dalla legge come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti”. Tale limite, affermano i giudici, ha rappresentato per il legislatore un ragionevole equilibrio tra esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell'ordine pubblico e le inevitabili conseguenze della commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni. Ciò premesso, ad avviso dei giudici la legge n. 242 indica le specifiche finalità per le quali la coltivazione della canapa è consentita, essendo essa (legge) diretta ai produttori e alle aziende di trasformazione, ma non tratta dei passaggi successivi nella filiera, e quindi non disciplina la commercializzazione al dettaglio della canapa oggetto della coltivazione semplicemente perché non deve disciplinarla!
In sostanza, secondo la Cassazione non può trascurarsi che è nella natura dell’attività economica che i prodotti della filiera agroindustriale della canapa siano commercializzati e che, in assenza di specifici dati normativi, non emergono particolari ragioni per assumere che il loro commercio al dettaglio debba incontrare limiti che non risultano posti nei segmenti precedenti della filiera.
La domanda da porsi, dunque, è se la disciplina sulle sostanze stupefacenti possa ancora riguardare la commercializzazione di prodotti dei quali è riconosciuta la liceità (sempreché la loro natura non debordi dai limiti fissati dalla legge n. 242/2016). E, dal momento che né il dPR n. 309/90, né norme successive all’entrata in vigore della legge n. 242 presentano contenuti che consentano di affermare questa conclusione, ne deriva, per la questione in esame, che “vale il principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei propri interessi”.
Su queste basi, “se il rivenditore di infiorescenze di cannabis provenienti dalle coltivazioni considerate dalla legge n. 242 del 2016 è in grado di documentare la provenienza (lecita) della sostanza, il sequestro probatorio delle infiorescenze, al fine di effettuare successive analisi, può giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato ex art. 73, comma 4, DPR n. 309 del 1990”.
Rimane invece ovviamente possibile che gli organi di polizia prelevino soltanto campioni (per non compromettere le esigenze economiche del venditore) delle infiorescenze per verificare il superamento del tasso soglia dello 0,6% di THC, dal quale potrebbero in ipotesi derivare sia la non ammissibilità della coltivazione, sia il sequestro preventivo dell’intera sostanza detenuta dal commerciante.
La posizione di chi sia trovato dagli organi di polizia in possesso di sostanza che risulti provenire dalla commercializzazione di prodotti delle coltivazioni previste dalla legge n. 242 del 2016 è quella di un soggetto che fruisce liberamente di un bene lecito, per cui la percentuale dello 0,6% di THC costituisce il limite minimo al di sotto del quale i possibili effetti della cannabis non devono considerarsi psicotropi o stupefacenti secondo un significato giuridicamente rilevante per il DPR n. 309/1990.
Dalla piena legittimità dell’uso della cannabis proveniente dalle coltivazioni lecite deriva che il suo consumo non costituisce illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 309, a meno che non emerga che il prodotto sia stato in qualche modo alterato e che di questa condizione chi lo detenga per cederlo sia consapevole. Da questa conclusione, peraltro, non deve farsi derivare l’automatismo per cui dal superamento dello 0,6% di THC nella sostanza detenuta derivi immediatamente una rilevanza penale della condotta, che, invece, andrà comunque ricostruita e valutata secondo i vigenti parametri di applicazione del DPR n. 309: per intendersi, dovranno provarsi le condizioni e i presupposti per la sussistenza del reato, che si configura solo se si dimostra con certezza che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, è di entità tale da poter
concretamente produrre un effetto drogante.
In ogni caso, se non è contestato che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite ex lege n. 242/2016, come per l’agricoltore, così anche per il commerciante, nel caso di sequestro dei prodotti a causa del superamento del limite dello 0,6% è esclusa la
responsabilità penale e, quindi, è ammissibile soltanto un sequestro in via amministrativa (ex art. 4, comma 7, della legge n. 242/2016): a una diversa conclusione potrà giungersi soltanto se risulti che il commerciante sia stato consapevole (ancora di più ovviamente se è stato artefice) di
trattamenti del prodotto successivi all’acquisto dal coltivatore e volti ad incrementare il contenuto di THC.